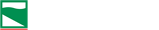Il territorio interessato dagli interventi del “GAL (Gruppo di Azione Locale) L’Altra Romagna” è costituito dalle aree pedecollinari, collinari e montane delle province di Ravenna, Forlì-Cesena
In termini di economia si può affermare che questo territorio, essendo geograficamente decentrato rispetto all’asse della via Emilia, lungo il quale si è sviluppato il sistema produttivo romagnolo, ha avuto un ritmo diverso di sviluppo che interessa, comunque, soprattutto il settore primario, ovvero agricolo e rurale, dell’economia, ma con aziende di dimensione contenuta. In crescita è il settore terziario, che risente delle nuove tendenze di vita orientata al salutismo e al benessere in virtù dei quali si organizzano servizi che incentivano il turismo.
Il settore manifatturiero continua ad interessare una importante fetta dell’occupazione che mantiene in loco soggetti che per diversi motivi non vogliono dedicarsi all’impresa agricola. La caratteristica territoriale, sia dal punto di vista socio-economico sia da quello ambientale, è l’omogeneità: foreste, parchi e riserve naturali, sorgenti termali, “giacimenti” di produzioni agricole di alta qualità sono il leitmotiv che si ripete dal crinale appenninico faentino al crinale appenninico riminese, passando per quello dell’ Appennino forlivese. Sono risorse naturali così radicate nelle storie locali che hanno dato valido stimolo allo sviluppo di servizi e imprese turistiche. Nel contempo si è avviato un processo per mettere a sistema la nuova offerta turistica, per collegarla in modo organico con la valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico e tradizionale delle diverse località
I Comuni compresi nell’area detta “L’Altra Romagna” sono 25 per un totale di popolazione che sfiora le centomila unità su un’estensione di più di 2100 Kmq. La provincia che più vi incide è la Provincia di Forlì-Cesena che con 20 Comuni, segue la Provincia di Ravenna con 5 Comuni.
Le Unioni Montane nel territorio del Gal L’Altra Romagna identificate sono 4: Unione della Romagna Faentina, Unione Montana dell’Appennino Forlivese, Unione Vallesavio, Unione Rubicone e Mare.
Origini del territorio ed evoluzione geologica
La visione aerea del territorio interessato dal Gruppo di Azione Locale denominato “L’Altra Romagna” consente di tracciare i lati di un immaginario quadrilatero, che possiamo identificare con la Romagna stessa, chiuso da due confini inequivocabili, a Est dal Mare Adriatico e ad Ovest dal versante orientale dell’Appennino, e segnato a Nord Ovest e a Sud Est da due linee all’incirca perpendicolari sia all’Adriatico, sia al crinale appenninico..Se da questo territorio escludiamo le pianure che ne occupano all’incirca i due settimi, abbiamo colline e montagne, ovvero ciò che è stato chiamato “L’ Altra Romagna”.
La morfologia del terreno ha geneticamente impresse le ferite di una lontana evoluzione geologica, durata milioni di anni, durante la quale il mare e la terra si contesero il primato, quasi ininterrottamente, e quando la seconda, accumulandosi e stratificandosi, emergeva dal primo questo, aiutato dalla forza di estremi cataclismi, la riconquistava invadendo di nuovo i litorali prima emersi.
Così si sono formati i rilievi collinari, oggi luoghi ameni dove noi amiamo trascorrere ore di svago o dove abitiamo, come in Val Lamone, a Brisighella, o in Val Senio, a Riolo Terme. Talvolta queste emergenze del terreno, oggi dolci colline, furono trascinate là dove l’uomo cominciò ad abitarle da cataclismi rovinosi ed esse si assestarono in posizioni più o meno inclinate o addirittura elevati in verticale (basti guardare da lontano il monte Titano seppure fuori, politicamente, dal territorio di nostro riferimento).Ma alcuni rilievi hanno avuto origine dall’evaporazione delle acque salmastre e paludose dove colonie di batteri riproducendosi provocarono la formazione dei gessi e degli zolfi, e siamo alle alture di Brisighella e Riolo Terme, ma anche del predappiese. Se poi ci fermiamo ad ammirare le colline argillose scavate dai caratteristici “ calanchi” dobbiamo ritornare indietro fino a trovare sotto la distesa marina, poi ritiratasi, una sedimentazione assai compatta ed in prevalenza argillosa (Brisighella, Riolo, Castrocaro) e quando raggiungiamo, in alto, il crinale dell’Appennino, oggi ricoperto dal generoso manto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ebbene quello fu il primo lembo di terra che emerse e vide la luce del sole, circa cinquanta milioni di anni fa.
Insediamenti umani
L’uomo nei millenni ha usato con intelligenza quello che ha trovato sotto i suoi piedi; i primi abitanti forse passarono su questo territorio, nel periodo del Paleolitico, come nomadi. Le prime tribù stanziali sono più recenti, tra il primo e il secondo Millennio a.C, e si dedicavano soprattutto alla pastorizia e a modeste forme di attività agricola, ma ci fu l’eccezione, poco dopo il Mille a.C, della civiltà Villanoviana (siamo nel Riminese) che ha lasciato i segni di una evoluzione dalla pastorizia ad una attività agricolo – industriale soprattutto a Verucchio.
In seguito la storia si è fatta con il susseguirsi di arrivi e partenze, di conquiste e sconfitte, dapprima dei Galli sulle popolazioni “appenniniche”, poi dei Romani sui Galli e in seguito ci furono gli Esarchi e i Longobardi e l’inizio della giurisdizione politica della Chiesa. Quando si entra nell’epoca medievale quasi ovunque, sulla sommità delle colline medio alte, si costruiscono castelli, rocche, fortilizi, torrioni. ma anche chiese e abbazie e si rafforzano e si ampliano le cinte murarie. Che saranno molto utili e per lungo tempo, a causa dei ripetuti conflitti e delle lotte di fazione e delle guerre scatenate dai Signori delle diverse dinastie insediatesi, chi a Faenza (Manfredi), chi a Forlì (Ordelaffi) e poi i Da Polenta a Ravenna e i Guidi in gran parte dell’Appennino.
Abitare oggi: promuovere e sviluppare
Le popolazioni odierne del territorio di riferimento hanno compreso l’importanza di questi segni della storia e, superato il periodo durante il quale l’andamento delle economie nazionali aveva indotto molti ad abbandonare i luoghi della propria storia familiare, (inurbamento) hanno ripreso possesso delle risorse agricole e hanno progettato e realizzato l’attento recupero delle opere edili (rocche, castelli, palazzi, chiese e abbazie e pievi), che fortunosamente avevano attraversato i secoli vincendo la sfida di guerre, terremoti e l’usura del tempo e l’incuria dell’uomo. In questi edifici, figli della storia, oggi si possono visitare musei ricchi di dote archeologica e storica, vi si organizzano mostre contemporanee, eventi musicali, attorno a queste memorie si è sviluppata la cultura della festa popolare che porta nella piazze e nelle strade il popolo e diventa sagra quando porta alla ribalta il frutto della terra, quei prodotti che nel passato furono il cibo per la sopravvivenza delle genti autoctone, castagne, frutta, ortaggi, uva, cereali e quant’altro ha sfamato l’uomo su queste terre.
Oggi tutto si vuole salvare e valorizzare, tutto ciò che è nato e cresciuto sotto il cielo e quanto scorre e vive sotto la terra, come le antichissime e preziose acque termali che a Bagno di Romagna, a Brisighella, a Riolo Terme continuano a dare benessere grazie alla conoscenza che le popolazioni ne hanno acquisito. E ancora sotto la roccia, grazie alla guida esperta di persone del luogo, si possono conoscere le meraviglie delle grotte e delle vie d’acqua sotterranee. Tutto il verde, poi, che ci circonda a 360° è a nostra disposizione, dalle verdi vie collinari tra gli uliveti e i vigneti fino alle fitte foreste, salendo verso le cime appenniniche, attraverso i parchi protetti e i boschi di castagni e di faggi.
Ospitalità
Non c’è angolo dove il visitatore si senta abbandonato. L’ospitalità degli abitanti, quell’atteggiamento che ovunque è sinonimo di Romagna, è diventata una capacità di servizio, ovvero si è trasformato in impresa turistica: sono gli hotel nelle località della risorsa termale, sono gli agriturismo sparsi nelle colline, sono i Bed &Breakfast che sempre più di frequente si aprono presso le famiglie, e gli ostelli per la gioventù e i campeggi. La cultura dell’ospitalità permea il territorio dal crinale appenninico, dove sono stati creati i Centri di visita alle foreste, (una porta di ingresso per una visita sicura, ma anche luogo di incontri e di approfondimento nella conoscenza della natura) fino alle località collinari dove ogni abitante si sente protagonista dell’offerta turistica e collabora attivamente alle innumerevoli iniziative che nell’ambito delle Comunità Montane a cicli continui si organizzano.
Prodotti tipici agroalimentari
Se, dunque, la visione aerea del territorio ci potrebbe consentire di distinguere, quasi in simultanea, le diverse fasce di territorio che digradano dall’Appennino verso la pianura, solo la paziente e curiosa esplorazione a terra, lasciando spesso le strade della grande percorrenza per imboccare quelle comunali o di frazione, e non sempre asfaltate, ci permette di entrare nel vivo della quotidianità delle Unioni Montane: si può entrare nel bosco di castagni e, con il permesso dei proprietari raccoglierne il frutto; con l’ autorizzazione del caso nel sottobosco si ricercano i funghi e i tartufi, i frutti di bosco sono la componente preziosa di rare confetture e composte che noi possiamo acquistare presso le aziende delle località montane, direttamente dal produttore o sui banchi di vendita alle Sagre; gli allevamenti di ovini, caprini e bovini, spesso piccoli, ma ottimi allevamenti ci procurano, grazie al lavoro dei casari, formaggi di grande sapore e genuinità, caratteristiche che diventano uniche quando le forme vengono lasciate a maturare nelle grotte, come quelle di Sogliano e di Predappio; gli allevamenti bovini che più connotano la nostra terra sono quelli della Razza Romagnola che offrono una carne di alta qualità certificata; ed i suini non sono da meno quando appartengono alla razza antica e ritrovata, detta Mora Romagnola; i frutteti si spingono fino ai 300 metri s.l.m e sono albicocchi, ciliegi, più giù kiwi e fichi e alle diverse altitudini una varietà di frutti antichi, detti “ dimenticati”, ma reintegrati nelle cucine locali; alcuni ortaggi si sono imposti per la loro perseveranza, cosi geneticamente motivata, come quella dello scalogno di Riolo Terme, da aver mobilitato risorse umane per una sagra annuale dedicata; sagre anche in onore del prugnolo a Cusercoli di Civitella (FC) e del bartolaccio a Tredozio (FC). Quando poi si giunge alle altitudini panoramiche delle prime colline ci si trova a camminare tra gli uliveti che spuntano ovunque, finanche nei giardini privati e qua e là i frantoi, privati o sociali: da Brisighella (RA), dove il frutto dei millenari ulivi dell’areale ha ottenuto la DOP, l’ulivo ci accompagna quasi interrottamente fino alla Valconca che gli consente di convivere addirittura nelle vicinanza dei castagni a Montefiore. Ma a queste altitudini l’incontrastato protagonista è il vigneto che continua indisturbato a produrre il frutto da cui l’uomo ha imparato a trarre il prelibato nettare: Sangiovese, Albana, Trebbiano, Cagnina, Pagadebit si contendono il favore del consumatore sulle mense quotidiane e degli intenditori nei conviti e nei locali della ristorazione di qualità, non più solo in Romagna ma sempre più diffusamente nei diversi continenti dove essi vengono esportati.
Prodotti tipici artigianali
L’ incontro ravvicinato con il territorio si potrebbe programmare alla ricerca dell’altra grande risorsa tipica che è l’artigianato: ognuna delle Unioni Montane conserva non solo il ricordo, ma l’arte viva che per i più diversi motivi nacque e si sviluppò in un paese o in una contrada. Questo è reso possibile dalla perseveranza e talvolta dal coraggio di uomini e donne che hanno scelto di proseguire ciò che nella propria famiglia i nonni e i padri avevano iniziato. Anche qui gli inizi ebbero spesso il loro pretesto nella natura del territorio o nelle necessità della vita quotidiana: là dove c’era la cava di argilla si costruivano recipienti e oggetti che poi si facevano cuocere nei forni, e ancora oggi i più svariati oggetti si forgiano, si cuociono, si smaltano e si decorano (Faenza, Rocca S.Casciano); l’argilla fu anche lo stimolo per la costruzione del “testo” o teglia che anticamente veniva usato per cuocere la piadina di Romagna e oggi due tegliai, marito e moglie, a Montetiffi, proseguono questa attività; per procurarsi utensili da lavoro i fabbri lavoravano, e tuttora lo fanno, il ferro forgiandolo e battendolo al fuoco; per coprire le bestie nei giorni del mercato si stampavano le tele colorandole a ruggine, oggi alcuni artigiani continuano a stampare le tele a mano secondo la tecnica tradizionale e le propongono come motivo di abbellimento delle casa o dei locali della ristorazione; un filone di pietra, forte e durevole, di colore grigio – azzurro, detta “Pietra Serena” e sfruttato già nel Medioevo, è stato riattivato nelle zone di Sarsina e Verghereto e ha dato stimolo all’attività non solo estrattiva, ma alla sua lavorazione in loco per trarne elementi originali, molto richiesti, per l’edilizia anche all’estero.