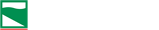La Storia
Le prime tracce dell’uomo nei territori appenninici romagnoli risalgono ad oltre 40 mila anni fa. Reperti rinvenuti in scavi organizzati o occasionali ci dicono qualcosa in più di quegli antichi o antichissimi antenati. Testimoniano, ad esempio, che a Verucchio, a partire dal IX secolo a.C. si sviluppò un centro che ha lasciato tracce straordinarie; che nel periodo umbro-etrusco si sviluppò la città di Mevanìola e l’abitato preromano di Sarsina; infine, che la conquista romana del territorio Appennino romagnolo iniziò dal basso, con la fondazione (268 a.C.), alla foce del Marecchia, di una colonia di diritto latino chiamata Ariminium, l’attuale Rimini. Con la conquista romana le città già esistenti aumentano di importanza e nella campagne si organizza l’operosa vita dei campi.
Ma nel periodo tardo romano la vita tende a concentrarsi nei centri principali (Ravenna, Sarsina, Mevanìola) e le strutture insediative minori iniziano il loro declino. Le invasioni barbariche (535-568) producono negli anni successivi un cospicuo regresso demografico, gli uomini tendono a rifugiarsi nei luoghi alti dell’Appennino e nascono le prime pievi. Nei territori intorno ad esse inizia a prendere forma la struttura feudale e i primi insediamenti plebano-castrensi.
Soprattutto dopo il Mille l’alto Appennino ospita la nascita di centri monastici di grande rilievo politico e morale che daranno un’identità indelebile a questi luoghi. I pellegrini romei che dalla pianura Padana si recano a Roma e gli scambi e i traffici indotti dal risveglio economico e sociale dei secoli XII e XIII, tracciano un itinerario lungo il quale sorgono ricoveri per viandanti e nuovi insediamenti, che finiranno per sostituirsi quelli plebano-castrensi e monastici. I secoli XII-XIV sono contrassegnati da aspre lotte feudali tra i signori locali su cui prevalgono fra gli altri i Guidi (nelle zone montane più elevate) e i Malatesta (nella fascia collinare cesenate e riminese) e a cui si aggiunge il potere temporale dei papi attraverso lo Stato della Chiesa.
Un potere che ben presto, grazie all’abile politica di penetrazione della Repubblica Fiorentina, che riuscirà laddove non avevano potuto le aggressive intemperanze dei signori feudali, verrà contrapposto a quello della Romagna Toscana. Dalla seconda metà del XIV secolo fino ai primi decenni del XV, infatti, i fiorentini tennero nell’alta Romagna un saldo potere condotto con mano leggera e grande equilibrio, attraverso vicariati e podesterie retti da rappresentanti inviati direttamente da Firenze. E mentre nello Stato della Chiesa si mantengono vivi i privilegi feudali, affidando a questo o a quel Signore amico le rocche e i castelli con relativo territorio, Firenze governa con il fascino e il peso di una civiltà dove arte, architettura e pensiero dominano per il loro alto livello. La Romagna Toscana si arricchisce di palazzi, ponti e strade di collegamento.
Romagna Toscana e Stato della Chiesa daranno conformazione a confini che si protrarranno fino all’Unità d’Italia. Solo nel 1923, per iniziativa di Benito Mussolini, una parte della Romagna Toscana confluirà nella provincia di Forlì.
L’Architettura
Due stili architettonici si individuano, fondamentalmente, nell’alta Romagna: quello più semplice, più povero ed essenziale della cultura contadina romagnola e quello più elegante e ricercato della Romagna Toscana.
La testimonianza di una ininterrotta civiltà contadina ha mantenuto intatta, nel corso degli anni, la struttura delle vecchie case rurali, costruite in sasso e in mattone, senza intonaco, all’interno della quali domina lo stanzone dell’ampio focolare, elevato contro il muro di due mattoni dal pavimento, con la sua vasta cappa affumicata.
Case ubicate sempre in pendio per consentire il fluire delle acque. Orientata a nord, immancabile, c’è l’aia: è un posto di lavoro, in terra battuta, fatto di cose precarie, quasi mai in muratura, contornata da siepi, alberi da frutto. Qui si trebbia, si spannocchia, vi razzolano gli animali domestici, si prepara la legna per il focolare, si parcheggiano i carri agricoli.
Il complesso rurale è, di fatto, il fulcro dell’azienda. Ogni sua componente esplica una precisa finalità nell’economia poderale. Conveniente riparo alle persone, ricovero per gli animali, luogo per la lavorazione dei prodotti dei campi.
Più tipico delle case padronali e dei palazzi inseriti in un contesto urbano fortemente influenzato dalla dominazione fiorentina è, invece, lo stile toscano. Si tratta di case più leggiadre, abbellite da archi, torrette, fregi, balconi in ferro battuto, stemmi sulle facciate. L’architettura fiorentina si legge nei ponti a schiena d’asino (Portico, Bocconi, Premilcuore, Modigliana); nei palazzi dei governatori (Bagno di Romagna, Terra del Sole) gemmati di decine di stemmi in pietra arenaria, caratteristica comune ai paesi nei quali Firenze inviava i capitani del popolo o podestà; nei palazzi e nelle vie di Modigliana; nel centro rimasto intatto di Portico, con i suoi palazzi nobiliari; negli stemmi, nei motivi ornamentali e negli architravi degli ingressi delle case di Rocca S.Casciano.
E’ Terra del Sole, tuttavia, la più bella espressione di questa cultura con le sue ampie piazze, con gli slanciati ed eleganti palazzi medicei, progettati dai migliori architetti del tempo: Baldassarre Lanci, suo figlio Marino, il Camerini, il Genga, il Buontaletti. C’è nel connubio fra i due stili l’anima dei territori dell’alta Romagna: l’asprezza dei luoghi e la ruvidità del carattere dei romagnoli, incontrandosi con la gentilezza e l’arte di Firenze, hanno dato luogo alla Romagna-Toscana.
Il Dialetto
“Non esiste un dialetto romagnolo – ebbe a dire Friedrich Schürr, famoso glottologo austriaco che del dialetto romagnolo si era occupato con passione – ma una infinità di parlate romagnole digradanti di luogo in luogo, quali continue variazioni su un fondo comune”. Di fatto il romagnolo costituisce un patrimonio lessicale assai ampio, riconducibile a una area geografica che si è formata fra influenze varie, invasioni, contese e campanilismi esasperati.
Tanto che il confronto può trasformarsi in un multiforme gioco del diverso su una radice comune.
Ed eccole alcune di queste variazioni. In gran parte dell’Appennino si usa burdèl per bambino, ragazzino; nel ravennate il termine diventa tabàc. Infine, chi non conosce il tipico amarcord (mi ricordo) felliniano, ebbene a Lugo si trova l’espressione am arcurd, molto simile al a m’arcurd della zona di Sarsina.
Ma due sono, fondamentalmente, le influenze che si possono leggere, pur nella difformità delle espressioni: quella toscana e quella gallica (il dialetto della pianura è abbastanza vicino ai suoni francesi). Parlata ricca di consonanti, dove le vocali a volte compaiono nel minimo indispensabile per rendere pronunciabili le parole (scièn per cristiano, sgnòr per signore), il romagnolo deve questa caratteristica alla colonizzazione gallica, che già dalla fine del V secolo a.C., contribuì a creare in Romagna una base linguistica sostanzialmente omogenea.
Un altro degli elementi di spicco del romagnolo, anche questo di chiara matrice gallica, è la forte accentuazione che tronca le vocali finali (parsòt per prosciutto, candlòt per candelotto, piat per piatto).
Gallicismi sono anche certi suoni nasali come vén per vino, pèn per pane.
Altrettanto riconoscibili sono gli apporti toscani tipici delle zone di confine: quattre (quattro) al posto del più tipico romagnolo quatar, ma anche ferme (fermo) al posto di ferum. O, ancora, l’espressione che tuttora si usa a S. Piero, somm al bòrg, la si ritrova nelle carte del Capitanato di Bagno in forma toscana sommo il borgo. Un altro esempio di forma dialettale toscaneggiante tipica della vallata del Savio fino al crinale appenninico è la u al posto del soggetto: u pienz, u andarà per piange e andrà.
A parte queste diversità, va sottolineato che il dialetto ha avuto forme espressive tipiche, quali le zirudeli, canzoni e filastrocche che hanno costituito un vero e proprio genere espressivo. Il vigore e la salacità di certi modi dire, a volte sin troppo schietti per un orecchio suscettibile, fanno comunque del dialetto una componente fondamentale di quel carattere gioviale e aperto che è la caratteristica riconosciuta della “romagnolità”.